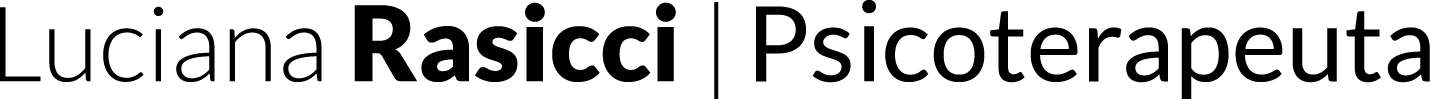IL DISAGIO DELLA POSTMODERNITA’
Psicanalisi e società (Luciana Rasicci)
Fiumi di antidepressivi scorrono per il pianeta. Gli occidentali, in un Occidente dilagante, globalizzante e trasversale, sono ormai neurotrasmettitori-dipendenti. Doping universale. Buonumore di Stato. Ottimismo di mercato. Obbligo al sorriso. Fondamentalismo genetico. Esistenzialismo neurologico. I modelli culturali propongono l’esaltazione della responsabilità individuale (merito, demerito o colpa) riguardo il benessere, inteso come successo sociale, o il malessere inteso come fallimento.
La responsabilità sociale non esiste più. Come sembra non esistere, ormai da decenni, una critica sociale da parte delle scienze umane e della stessa della psicoanalisi, convinta anch’essa ad una pratica utilitaristica che non oltrepassa il singolo e il presente. Lo psicanalista Miguel Benasayag in questo senso è una nobile e interessantissima eccezione (Benasayag, l’epoca delle passioni tristi, 2004, Elogio del conflitto, 2008).
Nella storia della psicoanalisi la critica sociale, in verità, è stata presente fin dalle origini. L’approccio socio-psico-analitico fu inaugurato da Wilhelm Reich e continuato da Erich Fromm e dalla Scuola di Francoforte. Più tardi la ritroviamo in Lacan e nei filosofi francesi degli anni Sessanta e Settanta; in Italia nella psicosocianalisi di Pagliarani e negli studi di Fornari sulla psicologia della guerra. Eppure negli ultimi tempi constatiamo un rinnovato interesse, per via dell’emergere di nuovi sintomi ed inedite forme del “disagio della civiltà” per il rapporto tra l’individuo e la società, tra il singolo e il suo tempo (Ehrenberg, 1999; Recalcati, 2010).
Eccitanti, calmanti, stabilizzanti dell’umore, molecole motivanti, alchimie che puntellano personalità stereotipate sull’orlo del collasso. Fiumi di antidepressivi serotoninergici attraversano, letteralmente, le nostre città: recenti analisi chimiche hanno trovato quantitativi abnormi di psicofarmaci – e di cocaina – nelle acque di fiumi come il Tamigi.
Stiamo così male? Con ogni probabilità sono lo stile di vita frenetico e la feroce competizione sociale a indurre le persone ad assumere stimolanti per accrescere il rendimento psicofisico: quasi fossero atleti o cavalli che si preparano a una gara. Ma quali fini e premi si aspettano i competitori al traguardo?
Nonostante la ricchezza dei beni materiali e degli strumenti tecnologici a disposizione di fasce sempre più larghe della popolazione assistiamo al dilagare dell’ansia, della depressione e dell’aggressività sociale. Non sembra semplicemente il benessere dunque il fine che la società rincorre.
Dopo un “capitalismo di produzione” di origine ottocentesca che prometteva lavoro per tutti e dopo il “capitalismo di consumo” del dopo guerra che ha reso possibile l’accesso al benessere materiale a tutte le classi sociali, quello attuale si può considerare, come teorizza Vincente Verdù (“Piaceta Mac Terra”, 2004), un capitalismo di finzione”. Mettendo a confronto i tre tipi di capitalismi Verdù scrive:
” Infine, il capitalismo di finzione, nato nei primi anni Novanta del ventesimo secolo, avrebbe messo l’accento sull’importanza teatrale delle persone (…). L’offerta dei due precedenti era quella di fornire alla realtà prodotti e servizi, mentre quella del terzo sarebbe di articolare e servire la realtà stessa, producendo una nuova realtà come massimo obiettivo. Vale a dire una seconda realtà, o realtà di finzione, con la parvenza di una vera natura migliorata, purificata, tornata bambina “.
” Questa seconda realtà generata come un sosia è l’ultima prestazione del sistema, così definitiva che il capitalismo stesso scompare come organizzazione sociale ed economica concreta per trasformarsi in civiltà, e passa da mezzo di sfruttamento a mondo tout court. Il migliore dei mondi?”
(Verdù, “Pianeta Mac Terra. Consumatori globali nell’epoca del capitalismo di finzione”, 2004)
Il capitalismo di finzione attribuisce grande valore all’affettività. Per mezzo della pubblicità mette in scena una realtà idealizzata che trasforma il cittadino in spettatore e poi in consumatore. I messaggi pubblicitari utilizzati nelle strategie di seduzione dall’economia di finzione si pongono come obbiettivo il benessere psicologico e la cura delle sensazioni e delle emozioni dei consumatori
A tal scopo offrono prodotti nei quali il “marchio” assume una valenza emozionale, valenza che vorrebbe indurre nell’acquirente l’impressione di poter “essere speciale” in un mondo speciale. È d’altronde la felicità il migliore dei prodotti…
L’universo della pubblicità produce intense stimolazioni sensoriali ed emotive. Gli spot commerciali si sono specializzati nell’evocazione sensoriale di mondi ideali e virtuali,nella proposta di modelli di identità e nell’offerta di style-life: vendono quindi apparenze, in una parola illusioni.
L’immaginario pubblicitario è alla base di quel sistema simbolico e valoriale che possiamo chiamarecultura dell’illusione. Nella cultura dell’illusione le diversità e le qualità individuali sono misurate e valutate, quindi tradotte in quantità e trasformate in prodotti da rivendere al pubblico come stile personale: uno stile che esprime una transitoria moda di stagione nella quale “essere unici” rappresenta unicamente il marchio, la griffe, che illude di poter essere allo stesso tempo globalizzati ed esclusivi, omologati e inimitabili.
Il sistema consumistico, tradotto in economia della finzione e in cultura dell’illusione, è oggi il Leviatano multinazionale che tutto ingloba: trasforma il dissenso in risorsa commerciale, finge l’appagamento dei bisogni e simula ad arte la diversità e persino la trasgressione.
Le soggettività sono sedotte e colonizzate da un sistema di valori che promette libertàe creatività nell’espressione di una propria unicità attraverso una molteplicità di scelte.
Le soggettività in realtà invece di “liberarsi”, come esigevanogli ideali di emancipazione del secolo scorso, sono state espropriate della vocazione all’autonomia e alla sana opposizione, e quindi della facoltà di scegliere e progettarsi liberamente l’esistenza.
Ognuno, nella cultura dell’immagine e nell’economia della finzione, può credersi libero di “realizzare se stesso”: illusoriamente, certo, ma conla leggerezza e la perseveranza di chi si sente supportato dalla conferma sociale.
L’adeguamento e il conformismo degli individui dimostrano la definitiva affermazione di un modello di personalità “come-se” (Helene Deutsch, in “Il sentimento assente”, 1942). Allo stesso tempo il vuoto lasciato dal tramonto delle identità tradizionali ha facilitato la comparsa di una psicologia di massa governata da un FALSO SE’ sociale globale che mette in scena un analogo modello di società “come-se”.
Siamo certo lontani dall’imposizione autoritaria di finzioni collettive e dalla manipolazione delle coscienze di una società “orwelliana” che opera un capovolgimento della realtà per mezzo dell’edificazione dei “Ministeri della Verità, della Pace, dell’Amore e dell’Abbondanza” (Orwell, 1950). Eppure nella nostra epoca si può ugualmente avvertire la sensazione di un sottile e continuo inganno.
La cultura dell’illusione costruisce scenografie che rappresentano la quotidianità comeuno spettacolo continuo sempre più simile alla “società dello spettacolo” teorizzata da Debord già nel lontan0 1967. Più che a una società orwelliana allora la nostra appare simile a quella descritta in “The Truman Show”, il film di Peter Weir che è diventato un emblema dell’inganno della postmodernità.
La realtà di Truman è quella di un mondo felice dove tra linde villette e steccati bianchi si consuma l’obbrobrio dell’indistinzione tra messaggi pubblicitari, scene di lavoro, vita famigliare, ricordi e fantasie; dove la biografia di ognuno è scandita da continui “jingle” e accompagnata ovunque da cordiali sorrisi da venditore.
Ma è tutta una finzione, a cominciare dallo slogan contenuto nel nome del protagonista che crede di essere un “true man”, un uomo vero. Inganno visibile a tutti. Tutti meno uno. Come a dire che nel nostro quotidiano “Truman show collettivo” tutti noi possiamo vedere e riconoscere le finzioni interpretate dagli altri. Ma non quelle che ci appartengono.
La crisi del capitalismo deflagrata nel collasso finanziario del 2008 ha portato alla luce l’illusionismo dell’economia di mercato: un illusionismo presente fin nelle attività precipue del capitalismo postmoderno – la “finanza-capitalismo” – il quale si basa più sulla speculazione finanziaria che sul mercato. Ciò porta a una simulazione non solo del valore delle cose ma del denaro stesso. Il valore reale del lavoro e delle merci è stato prima surclassato da quello creato dalle transazioni commerciali; oggi assistiamo anche all’alienazione del surrogato universale per eccellenza, il denaro.
La crisi drammatica e ricorrente e del mondo illusionista della finanza appare come la metafora viva e concreta dell’incrinarsi della finzione identitaria dell’uomo postmoderno. Viceversa possiamo considerare il crollo del falso Sé nel microcosmo individuale (che ha prodottole nuove psicopatologie come l’attacco di panico) come il sintomo della crisi di un intero sistema sociale.
Nella postmodernità sembra concretizzarsi la profezia finale diMarx: “gli individui stanno subendo l’estraneazione di sé, come, prima, l’estraneazione della cosa ” (K. Marx, “Manoscritti economici-filosofici”, 1884, p.76). L’alienazione del lavoro conduce l’uomo all’estraneazionedagli oggetti che egli stesso produce e successivamenteall’allontanamento dai propri simili: l’alienazione svuota di senso le qualità che definiscono l’appartenenza al ge-nere umano. In sostanza dal lavoro alienato si passa all’alienazione dell’uomo da se stesso.
Solo qualche decennio fa era il ruolo socioeconomico che le persone rivestivano ad essere vissuto come alienante, cioè come una limitazione alle proprie potenzialità: era il ruolo che alienava, mentre oggi è la persona stessa a sentirsi alienata. La liberazione dal lavoro e del lavoro – l’utopia espressa dagli ideali socialisti ottocenteschi di poter essere allo stesso tempo medico, insegnante, contadino, artigiano o perfino poeta o pittore – sembra un ideale del tutto superato. Il poter essere altro al di là dell’identificazione con il proprio ruolo lavorativo non interessa più nessuno. Ci si accontenta magari di un hobby compensativo da svolgere nel weekend.
Chiedere oggi alle persone di rallentare – muoversi, pensare, sentire, respirare, “lavorare con lentezza” come nel fortunato slogan del movimento del ‘77 bolognese – è come chiedere ad un’auto di grossa cilindrata di andare agli ottanta all’ora. Proprio come per le macchine costruite dall’uomo ci si deve chiedere a che serve tanta potenza e tanta fretta se la circolazione non consente, pena lo stress o la catastrofe, di superare i limiti. Le nostre attività andrebbero riconsiderate e ridefinite in modo da non superare i confini dell’umano.